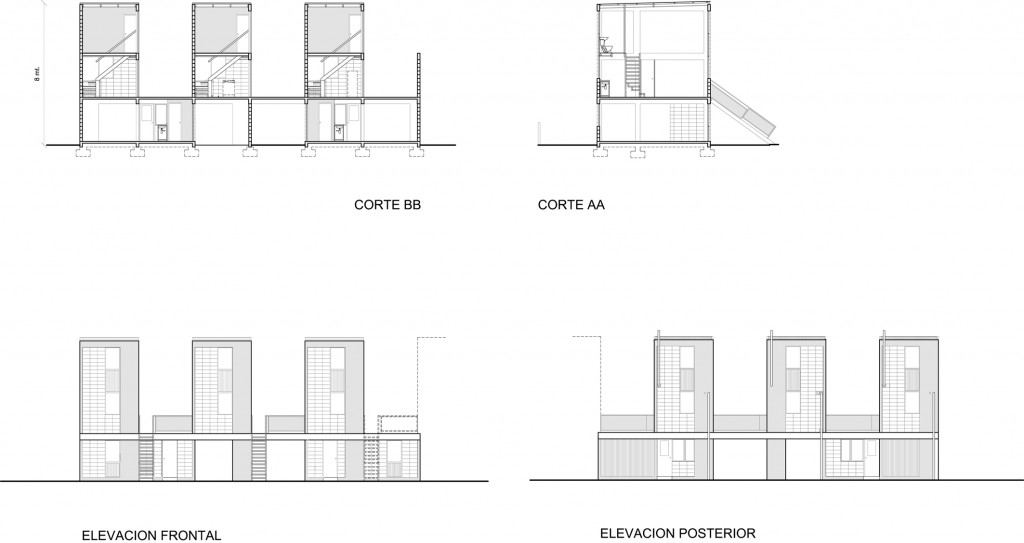critical text by Joseph Grima
Flipping through an architecture magazine or clicking through the feed of one of the countless architecture blogs online today, it quickly becomes evident that contemporary architectural production suffers from a chronic case of hyperinflated personality syndrome (a pathology which causes buildings and their authors to engage in an agonistic rivalry for the limelight, both within the city and within the collective consciousness of its inhabitants).
Pondering the possible causes, one is tempted to suspect that the addiction to public attention is in fact a consequence of the profession’s marginalisation: few times in history have architects had as little influence on the form of the urban landscape that surrounds them as in the last two or three decades of developer-driven urban expansion. Little wonder that when they actually do get to shape a portion of the city – something that is entirely the exception and not the norm – the primary ambition is to project a larger-than-life personality, to create a strident landmark that compensates for a general sense of impotence over its context.
Even in the days when ambitions were greater and the belief that serving society was possible endured, a top-down attitude to planning and urbanism doomed many projects at best to formal alteration and at worst to demolition. Le Corbusier’s dwellings in Pessac were customised beyond recognition by their working-class inhabitants, much to their author’s chagrin; Stirling, Kikutake et al’s housing in Previ (Lima, Peru) suffered a similar fate, given that the integrity of formal compositions designed by members of Team X held little value when the need to add an extra room arose.
Quinta Monroy is therefore doubly exceptional. Not only does it renounce formal ambitions of any kind, but it actually bows to the inevitable and embraces the change its inhabitants will inevitably desire. It is an architecture-as-framework, a support structure that renounces its own personality in favour of its inhabitants’. If, as a profession, we genuinely aspire to become even remotely relevant in shaping the landscape that surrounds them, we would do well to consider architecture as a service to society rather than a vehicle for our vanity.
***
Sfogliando una rivista di architettura o cliccando in uno degli innumerevoli blog di architettura online oggi, appare ben presto evidente che la produzione architettonica contemporanea soffre di una sindrome cronica da personalità megalomane (una patologia che fa sì che gli edifici e chi li ha concepiti siano impegnati in una rivalità agonistica nella ricerca della ribalta, sia all’interno della città che all’interno della coscienza collettiva dei suoi abitanti).
Riflettendo sulle possibili cause di tale fenomeno viene il sospetto che la dipendenza nei confronti dell’attenzione pubblica sia una conseguenza della marginalizzazione della professione dell’architetto: poche volte nella storia infatti gli architetti hanno avuto così poca influenza sulla forma del paesaggio urbano che li circonda come negli ultimi due o tre decenni di espansione urbana guidata dagli agenti immobiliari. Allora c’è poco da meravigliarsi se, quando devono disegnare una porzione di città – cosa che è assolutamente l’eccezione e non la regola –, l’ambizione primaria sia quella di proiettare una personalità esagerata, di creare un oggetto isolato che compensi un senso generale di impotenza verso il suo contesto.
Persino nei giorni in cui le ambizioni erano maggiori e la fiducia che servire la società era possibile, un siffatto approccio alla progettazione e all’urbanistica dominava molti progetti, traducendosi nel migliore dei casi in alterazioni formali e nel peggiore in demolizioni. Le abitazioni di Corbusier a Pessac erano personalizzate a tal punto dai loro abitanti della classe operaia da non essere riconoscibili, con gran delusione del loro ideatore. Le case di Stirling, Kikutake e altri a Previ (Lima, Peru) hanno avuto un destino simile, visto che l’integrità delle composizioni formali progettate dai membri del Team X ebbe poco valore quando sorse l’esigenza di aggiungere una camera extra.
Quinta Monroy pertanto è doppiamente eccezionale. Non solo rinuncia a qualsiasi tipo di ambizione formale ma si inchina all’inevitabile e abbraccia i cambiamenti che i suoi abitanti inevitabilmente desidereranno apportare. È un’architettura-scheletro, una struttura di supporto, che rinuncia alla sua personalità a favore dei suoi abitanti. Se, a livello professionale, aspiriamo genuinamente a esercitare una seppur remota influenza sul disegno del paesaggio che li circonda, faremmo meglio a considerare l’architettura come un servizio alla società piuttosto che come un veicolo della nostra vanità.
The text is presented at the exhibition L’architettura che ti piace©/The architecture you like© opened at MAXXI, Rome until 15th May 2011. Info www.fondazionemaxxi.it
Il testo è presentato alla mostra L’architettura che ti piace©/The architecture you like© visitabile al MAXXI di Roma fino al 15 maggio 2011. Info www.fondazionemaxxi.it
Milano, 25 luglio 2011